Sebbene uscito nel 1999, scopriamo oggi un testo di Domenico Losurdo nella nuova edizione datata 2012, rivista e ampliata dall’autore. Colpevolmente in ritardo, decidiamo comunque di recensirlo soprattutto per la stima che proviamo verso uno dei rari studiosi, appartenenti al sistema universitario ufficiale, non piegati alle retoriche dominanti e alle mode accademiche del momento. Con una coerenza che gli fa onore, Losurdo ha col tempo mantenuto dritta la barra dell’antimperialismo, con la sua produzione teorica e la sua attività politica. Nonostante questo, non nascondiamo lo stupore per certe tesi avanzate nel presente testo, e nel recensirlo non possiamo che catalogare tale libro fra gli “sconsigli” per gli acquisti.
Il testo, in realtà composto da un insieme di saggi e articoli scritti in momenti diversi, dal 1999 al 2011, ha l’ambizione di tracciare una sintesi storica delle rivoluzioni russa e cinese, di comprendere l’attualità di quelle esperienze nonostante i molti anni passati dal crollo del socialismo a est e dalla profonda riforma del “socialismo” cinese. Nel farlo, l’autore si concentra soprattutto sulla via intrapresa dalla Cina post-Mao. E’ proprio il discorso sullo sviluppo cinese ad essere per noi irricevibile. Secondo l’autore, in Cina è in corso una gigantesca NEP di lungo periodo, unico modo che aveva il paese per uscire dalle secche in cui l’aveva condotta la rivoluzione culturale maoista e unico strumento per il socialismo di reggere la competizione internazionale e l’aggressività dell’imperialismo statunitense. Detto in termini piuttosto chiari, che non consentono fraintendimenti, Losurdo dichiara il processo in atto in Cina l’unica forma concreta e realizzabile di sviluppo del socialismo: ogni altro strumento è bollato come idealista e inevitabilmente destinato ad essere spazzato via dalla storia. Questa visione delle cose non può non lasciarci perplessi. L’autore teorizza, con riferimenti a Marx stesso, che il socialismo per abbattere il precedente sistema deve sviluppare al massimo grado le forze produttive di un territorio. Nel farlo, l’unico strumento che sembra essere efficace è sviluppare il capitalismo stesso, che sarebbe in definitiva l’unico modello che consentirebbe al sistema produttivo di sviluppare tali forze economiche. In sintesi, una volta preso il potere politico, la direzione comunista dovrebbe guidare lo sviluppo di un sistema capitalista al suo massimo grado, con l’obiettivo di generare ricchezza che in un successivo momento dovrebbe essere redistribuita. Senza sviluppo delle forze produttive, il socialismo si trasformerebbe solo in un sistema di redistribuzione della povertà, che porterebbe inevitabilmente il sistema stesso a crollare, afferma in più passaggi il professore. Questa dinamica è oggi presente in Cina, e soprattutto è presente nella Cina dopo Mao, e l’autore sembrerebbe bollare Mao come ancorato a una concezione “sovietica” della gestione delle risorse, contrapposta alla visione riformatrice di Deng Xiaoping e successori che invece avrebbero compreso questo fatto e raddrizzato la barra dello sviluppo cinese, rendendolo competitivo, dunque vincente.
Secondo Losurdo, d’altronde, “quale sarebbe l’alternativa? Soprattutto dopo la crisi e la dissoluzione dell’Unione Sovietica e del “campo socialista” non è più possibile isolarsi dal mercato mondiale capitalistico a meno di non condannarsi all’arretratezza e all’impotenza. Nelle nuove condizioni dell’economia e della politica mondiale, l’isolamento sarebbe sinonimo di rinuncia sia alla modernità che al socialismo. Pur coi suoi alti costi, il risultato del nuovo corso è sotto gli occhi di tutti: uno sviluppo delle forze produttive assai accelerato, un miracolo economico di dimensioni continentali, l’accesso di centinaia di milioni di cinesi a diritti economici e sociali in precedenza mai goduti e dunque la messa in moto di un processo di emancipazione di enormi proporzioni”. Questo è solo uno dei molti passaggi, neanche dei più netti, in cui si giustifica la restaurazione del capitalismo in Cina tramite la superiore necessità di sviluppare le forze produttive fino al massimo grado. La prova che l’autore porta per legittimare la giustezza del processo in corso sarebbe l’uscita dalla sussistenza e dalla povertà di milioni di cinesi, che confermerebbe il processo in sostanza progressivo della linea intrapresa. Non possiamo che rimanere sconcertati da argomentazioni di questo genere, che partono da un concetto giusto e che condividiamo, e cioè che la lotta di classe non è solo tra padroni e lavoratori ma anche tra nazioni sfruttate e nazioni imperialiste, ma che viene distorto oltremodo fino a tendere ad un giustificazionismo del processo cinese qualsiasi ne siano le tendenze. Vediamo di seguito il perché, cercando di essere il più possibile analitici e sempre tenendo presente che Losurdo è, come detto, un compagno che stimiamo, e che quindi si tratta di una dialettica in seno alla stessa parte politica, e come tale da valutare in maniera propositiva.
Partiamo dalla fine, e cioè dalla prova che riecheggia come un mantra nel corso dei vari saggi che compongono il libro: l’uscita dalla povertà di milioni di cinesi è la prova che l’esperimento in corso, con tutte le sue storture, sostanzialmente funziona e va verso la giusta direzione. Ci sembra una motivazione estremamente debole. Nel corso dello sviluppo economico capitalista, ogni singolo contesto andato incontro a industrializzazione ha visto crescere le possibilità economiche per la classe lavoratrice. Nell’Europa devastata del dopoguerra, tanto per fare un esempio, un trentennio di “sviluppo delle forze produttive” ha portato con sé, oltre tutti i mali che conosciamo, anche uno sviluppo economico per le popolazioni interessate. Passando dalla società contadina a quella dei consumi, è il capitalismo stesso che ha richiesto la formazione di una vasta fascia media di popolazione che potesse permettersi di comprare quello che produce lavorando. Insomma, in sintesi, se la prova della giustezza del socialismo di mercato è l’uscita di milioni di persone dalla povertà, questo vale anche per il capitalismo. E’ il capitalismo stesso che garantisce, per le popolazioni del centro produttivo, un innalzamento delle condizioni di vita, e lo garantisce perchè necessita di un mercato di sbocco dei prodotti. E tralasciamo il fatto che parte di questo innalzamento del tenore di vita sia determinato dalle lotte di classe, che mirano a strappare quei margini di profitto che il padronato punta a tenere per sé, in una dialettica storica senza termine se non nel superamento di tale contraddizione.
Altra considerazione: oggi i mercati, tanto quelli controllati dal capitalismo tanto più sotto l’etichetta del socialismo, necessitano di tutto tranne che di uno “sviluppo delle forze produttive”. Qui l’autore sembrerebbe incorrere in un errore teorico di fondo. Il sistema capitalista va incontro a periodiche crisi da sovrapproduzione proprio perché sviluppa troppe forze produttive. Infatti la crisi da sovrapproduzione è determinata dal sistema economico che produce troppa merce, e l’ingolfamento produttivo fa crollare il saggio di profitto che ogni merce porta con sé. Il capitalismo, in sintesi, non uscirà da questa crisi “producendo di più”, ma producendo diversamente, disperdendo parte di quei profitti. Se tale dispersione avverrà nel pieno di un ciclo di forti lotte di classe, questa prenderà la forma di una redistribuzione della ricchezza dai profitti ai salari. Storicamente, l’unica opzione del capitale destinata a riattivare la dinamica del saggio di profitto è la distruzione artificiale dello stesso, ad esempio tramite guerre tra imperialismi. Vista che questa, la caduta tendenziale del saggio di profitto, è una tendenza storica addirittura accettata dagli economisti neo-liberali, per quale motivo uno stato socialista dovrebbe teorizzare un difetto del sistema di produzione capitalistico e farlo proprio? In Cina è presente una straordinaria ricchezza economica che però non viene ripartita fra i suoi produttori, ma rimane nei circuiti finanziari e bancari o utilizzata nella gestione di una economia di mercato centralizzata ma non socializzata. Basterebbe a chiarire ogni dubbio proprio il processo di delocalizzazione industriale capitalista verso la Cina: l’occidente industriale vuole produrre in Cina perchè trova territori in cui l’assenza di diritti e di emancipazione del lavoro consentono enormi risparmi e dunque enormi profitti.
Terza questione: se il socialismo, una volta giunto al potere, non dovesse far altro che sviluppare il capitalismo, perché dannarsi l’anima per conquistare un potere che non comporterebbe alcuna rottura storica col sistema precedente? E’ utile ricordare, infatti, che il capitalismo è, nella sua sostanza, un rapporto sociale. E’ cioè l’istituzionalizzazione di un rapporto tecnico tra capitale e lavoro. Il mondo antico cambia la sua forma di sviluppo quando il rapporto sociale tra lavoratore e capitalista diviene la norma del progresso economico dei nascenti Stati nazionali. La rivoluzione socialista deve rompere quel rapporto, che è l’unica sostanza attorno alla quale variano i diversi tipi di capitalismo. Se una volta preso il potere quella dinamica non viene cambiata, ma anzi si teorizza l’incentivazione, non esiste più alcuna differenza tra sistema capitalista e sistema socialista. Rendendo inutile, controproducente e sicuramente per nulla attraente ogni processo rivoluzionario (difficilmente al lavoratore interessa di che colore sia il padrone di turno, se sempre padrone rimane e allo stesso grado di sfruttamento).
Queste riflessioni tengono peraltro in conto della difficoltà di un percorso concreto verso il socialismo, che è un percorso storico, e non idealizzato. Una rivoluzione, cioè, non cambia dall’oggi al domani i rapporti di produzione, senza contare l’isolamento internazionale e dunque le necessarie mediazioni a cui andrebbe inevitabilmente incontro. Ma questo non toglie che o un esperimento socialista punta all’abbattimento del rapporto sociale tra capitale e lavoro, oppure non è un esperimento socialista. In Cina sono già più di tre decenni che è avviata l’opera di restaurazione capitalistica, e questo lo percepiscono non tanto gli ideologi anti-comunisti, ma gli stessi lavoratori cinesi, espropriati di tutto tranne della propria forza lavoro, messa a disposizione di uno sviluppo economico che non li riguarda. Non bastassero i lavoratori, la dinamica stessa dell’imperialismo statunitense, volto alla partnership economica con la Cina, dovrebbe fugare ogni dubbio. Chiaramente le briciole del sistema giungono anche a quei lavoratori, e la necessità di sviluppare un mercato interno autosufficiente porterà sempre più ad innalzare le condizioni di vita di una parte della classe operaia cinese. Ma questo non rappresenta alcuna prova della giustezza di quel processo: reitera solo una dinamica capitalista già vista storicamente in tutti i contesti dove questo si è potuto sviluppare efficientemente (e alle spese di milioni di schiavi delle colonie).
L’unico aspetto che possiamo rilevare in maniera favorevole nel modello di sviluppo cinese è che esso non si caratterizza come “imperialista”. Infatti, nonostante la restaurazione capitalistica, la Cina non si sta contraddistinguendo come potenza imperialista, per varie ragioni. Primo, perché non esporta guerre, neanche indirettamente. Secondo, perché nonostante la pace tra concorrenti stabilita con gli Stati Uniti, la Cina è sempre in prima fila nell’aiutare tutti quegli Stati che in un modo o nell’altro si richiamano al socialismo o che costituiscono un problema politico per l’imperialismo statunitense o europeista (ad esempio, Cuba e Venezuela). Terzo, perché non esporta modelli di capitalismo privato slegato dagli interessi statali. Questi tre fattori rendono la Cina un paese sicuramente capitalista ma non legato a dinamiche imperialiste, almeno nel senso che queste hanno nelle definizioni di Lenin e viste nello sviluppo storico concreto del Novecento. Questi fattori rendono la Cina un paese a sé, che ha abbandonato la strada del socialismo ma che ancora non è definibile secondo passati canoni storici. Ma non possiamo negare l’evidenza di un processo storico in sostanza avverso agli interessi dei lavoratori, tanto cinesi quanto internazionali.




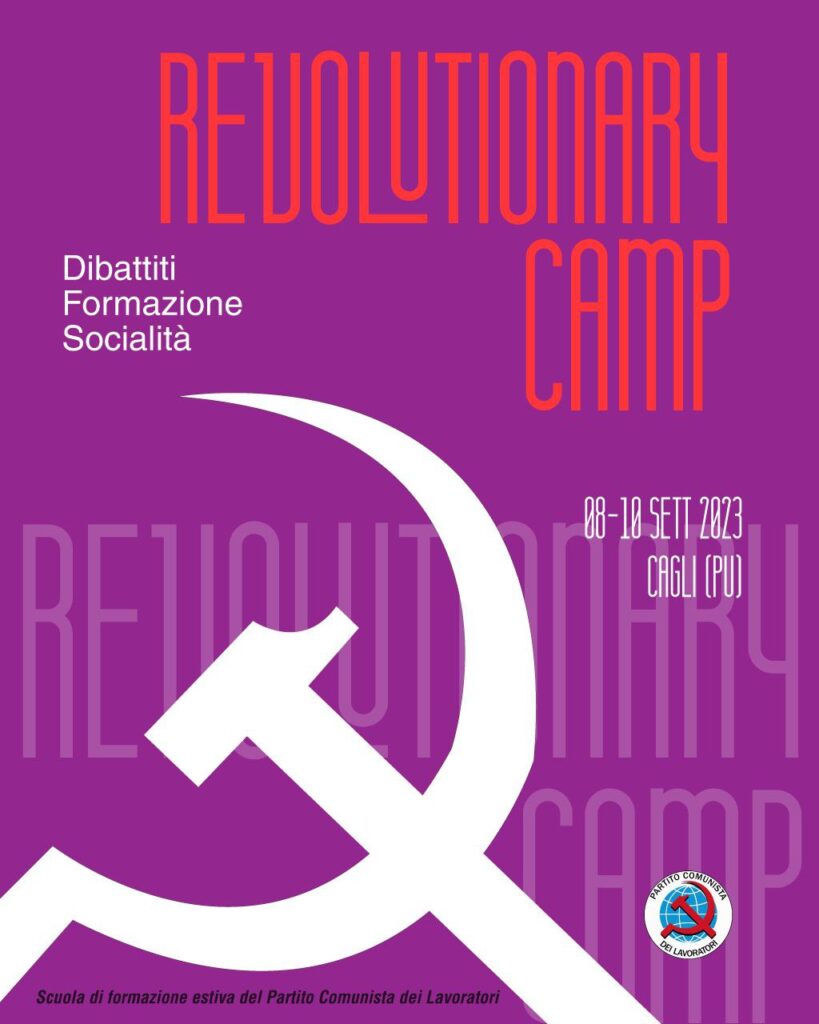









La recensione dei compagni di Militant è buona; mi lascia un po' perplesso il terzo e ultimo punto sulla Cina non imperialista: “esportare modelli di capitalismo privato…” è un'espressione che in sé praticamente non dice nulla. E' forse più utile notare che lo strato borghese cinese (che al momento non mi pare organizzato, non è insomma classe per sé) negli ultimi decenni si è espanso economicamente ma anche “sovrastrutturalmente” (conducendo battaglie egemoniche DENTRO e fuori il PCC, ritagliandosi uno spazio politico nella stessa Cina); oggi abbiamo capitalisti cinesi “fuoriusciti” e che mano a mano si integrano nelle nazioni dove hanno le loro basi, e una borghesia cinese privata, di fatto slegata dallo Stato, che gioca la sua partita nel mercato mondiale.